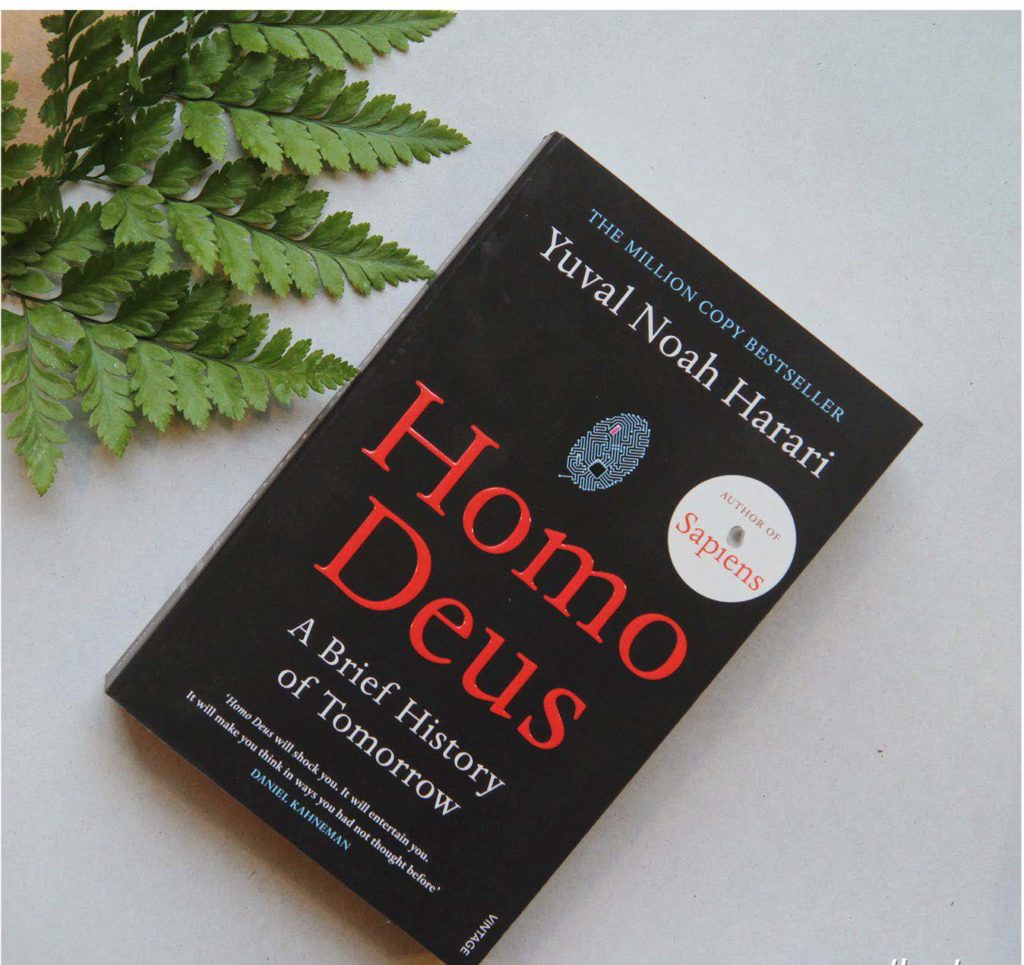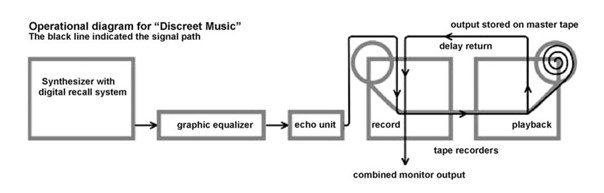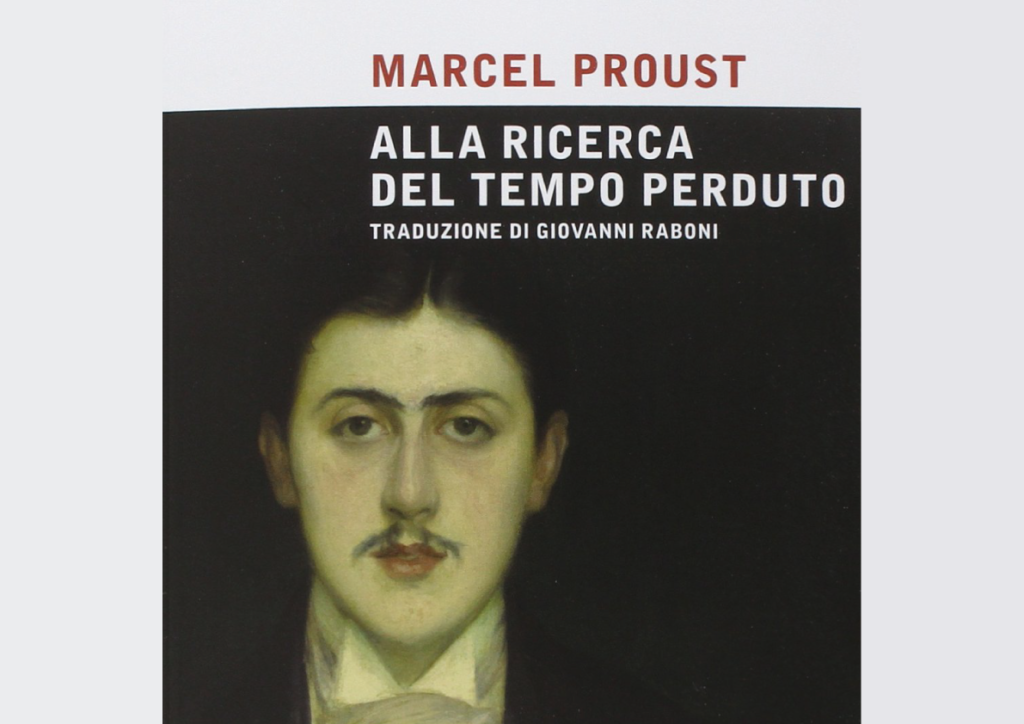Siamo Liza e Victoria due terapeute messicane che fanno parte della comunità, la prima residente in Messico e la seconda in Italia. Lo scorso giugno abbiamo avuto l’opportunità di assistere allo sviluppo del mese dell’orgoglio LGBT+ in due paesi diversi, Italia e Spagna e, per molti anni, anche in Messico.
Abbiamo deciso di scrivere questo testo a seguito delle conversazioni avviate sulla quantità di contrasti che abbiamo percepito muovendoci in questi tre contesti ed abbiamo sentito il bisogno di aprire questo dialogo. Aprire il dialogo significa per noi rendere pubblico ancora e ancora ciò che tende a rimanere privato e che, durante i due anni della pandemia globale, si è ulteriormente esacerbato. Marciare nuovamente è stato importante per noi perché siamo testimonƏ del fatto che quando il dialogo si svolge in pubblico, acquista più forza di quando si svolge tra quattro mura.
Negli ultimi 50 anni e a partire dalla rivolta di Stonewall, che è stato l’evento catalizzatore affinché la comunità LGBT+ si organizzasse per lottare per i propri diritti, a fine giugno – il 28 o una data vicina – si commemora la Giornata dell’Orgoglio almeno in un posto al mondo.
In un paese su tre l’essere omosessuale è vietato, mentre in 12 paesi è punito con la pena di morte. Il matrimonio egualitario è legale solo in 30 paesi e fra questi non vi è l’Italia.
Il Messico è il secondo paese in America Latina con il maggior numero di violenze omofobiche e transfobiche. La Spagna, sebbene sia uno dei paesi leader in Europa in termini di tutela dei diritti umani, è lo scenario di numerose aggressioni omofobiche che avvengono in spazi pubblici.
Anche se attualmente in Italia, Spagna e Messico si marcia ogni anno in occasione del Pride, la prima marcia in Spagna si è svolta nel 1977, in Messico nel 1979 e in Italia nel 1994. Questo è un fatto importante per noi sotto molti aspetti e uno di questi è la rilevanza che i diritti della comunità hanno raggiunto, per ragioni diverse, in ognuno di questi contesti.
Per noi, vivere la marcia quest’anno ha rappresentato uno spazio di discussione e riflessione, sia a livello personale che collettivo.
Io, Liza, donna cis, messicana, bianca, lesbica.
Io, Victoria, donna cis, messicana, meticcia, immigrata, bisessuale.
Marciamo perché siamo vive per farlo, grazie alla lotta che altrƏ hanno portato avanti, perché anche se non ci sentiamo ancora completamente al sicuro nello spazio pubblico per amare chi vogliamo, viviamo in paesi in cui non è illegale farlo. Marciamo perché non abbiamo mai avuto o sentito il bisogno di fare coming out, ma sappiamo che è un privilegio farlo, perché veniamo da famiglie che a volte abbracciano e a volte rifiutano.
Marciamo perché abbiamo lo stesso diritto ad amare delle persone etero, perché l’orgoglio è pubblico, è collettivo, è la libertà del potere, è la celebrazione di ciò che è stato raggiunto e la lotta per ciò che deve ancora venire. È una forma di resistenza, di visibilità, di insistere nell’amare a letto come nelle strade. Perché anche il piacere, l’amore, la lotta, il corpo, le strade e l’esistenza ci appartengono.
Perché la marcia diventa uno spazio fisico che accoglie la lotta non solo di un giorno o un mese intero. Perché le conquiste della comunità LGBT+ si intrecciano con i trionfi e le fatiche dei Movimenti Verdi e Viola, perché i movimenti femministi hanno aperto la discussione sul tema della sessualità, del genere e della politica ed è attraverso “il personale è politico” che tutte le individualità possono trovare un alveo comune.
Perché parlare di diritti umani deve aprire il dialogo su tutto ciò che storicamente è stato evitato, per motivi morali e religiosi, mantenendo i discorsi nel privato o nell’oblio. Perché partiamo dal presupposto che la nostra esperienza personale di attivismo può generare movimento e cambiamento solo se viene collettivizzata.
Marciamo e alziamo la voce perché siamo anche terapeute e situarsi in questo spazio, personale e professionale, è stato – e continua ad essere – un apprendimento di preparazione teorica, fisica, psicologica ed emotiva. Perché non siamo fatte di fede ma di speranza, perché ci piace stare dentro l’uragano e non siamo nella posizione di essere indifferenti. Provocare movimento e metterci in discussione nel nostro contesto, insieme ai nostri gruppi di appartenenza e insieme a i nostrƏ clientƏ, è una necessità e un impegno.
Non concepiamo un lavoro terapeutico che non tenga conto dell’intersezione delle lotte per i diritti umani, che non metta in discussione le idee della psicologia tradizionale, che fino al 1973 considerava l’omosessualità come un disturbo e continua a considerare la disforia di genere come tale. Perché facciamo parte dei sistemi istituzionali – compreso il sistema sanitario – che continuano a discriminare i membri della comunità, attraverso la negazione delle cure mediche, il divieto di donare il sangue, la discriminazione nell’accesso al lavoro e all’istruzione, oltre a molte altre forme di violenza. Perché molti operatori sanitari – compresƏ i psicologƏ – continuano a lavorare per correggere e non per capire e accompagnare.
Scriviamo questo articolo per celebrare ciò che è stato raggiunto e per invitare al dialogo su ciò che ancora manca. Il confronto tra le nostre esperienze in tre paesi diversi ci ricorda quanto siamo fortunate a provenire da un paese in cui il matrimonio LGBT+ non è ancora legale a livello nazionale, ma dove possiamo scegliere di sposare chi vogliamo. Tuttavia, la libertà e la sicurezza che abbiamo provato marciando in Spagna ci fanno desiderare di poterci sentire allo stesso modo camminando per le vie del Messico. Da parte sua, il Modello Dialogico è stato in Italia uno spazio per essere irriverenti, per essere curiose, per situarci.
Perché la lotta collettiva si svolge nelle strade, ma anche nei nostri studi, mettendo in dialogo ciò che non viene nominato, ciò che è stato messo a tacere, ciò che a volte non vediamo nemmeno noi; si tratta di intessere e disfare assieme, delle conversazioni che commuovono e trasformano. Si tratta del fatto che il professionale è anche personale e il personale è sempre politico.
Liza Pérez-Moreno Rosa
Victoria Cervantes Camacho